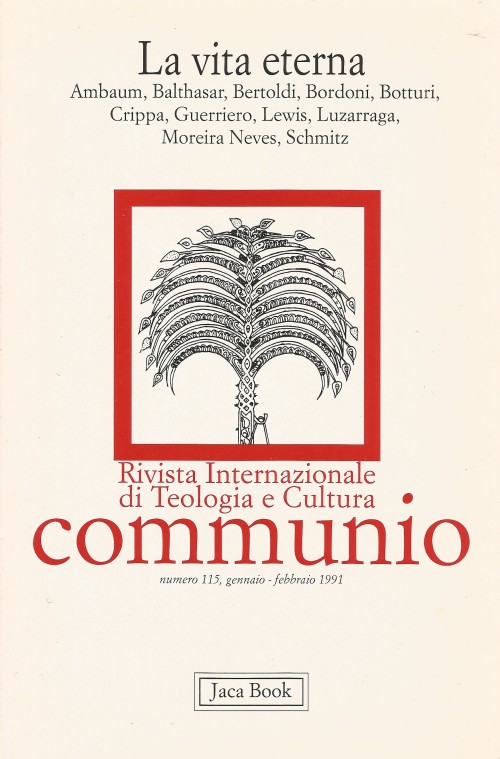
Contemplazione e metafisica
Presupposti metafisici della “contemplazione nel concreto”
Pubblicato su Communio, n. 115, gen-feb 1991, pp. 109-126.
Questo contributo si pone come prosecuzione di un precedente articolo [1], in cui avevamo tratteggiato l’idea di contemplazione nel concreto, e visto in modo molto sommario quali ne siano le implicazioni nell'ambito di una cosmologia filosofica. Si tratta ora di vedere a quali condizioni metafisiche sia pensabile quella idea. Noi dunque non facciamo un discorso metafisico strictu sensu (in particolare non pretendiamo di dimostrare alcuna tesi metafisica); piuttosto, avendo come orizzonte dato quello della contemplazione nel concreto, ci chiediamo quali tesi metafisiche meglio vi si attaglino [2].
1. Premessa: legittimità della metafisica
a. Nonostante quanto appena detto non ci pare possibile sorvolare del tutto il tema della legittimità della metafisica (in se stessa). In realtà p. 109 nell’attuale temperie culturale parlare di metafisica non è così proibitivo, come lo era anche solo una decina di anni or sono, quando imperavano forti pregiudizi, di bassa lega intellettuale, ma di grande effetto psicologico [3]. Vediamo ora invece rifiorire al riguardo interesse e studi,condotti con pregevole serietà [4].
In effetti la metafisica, dal punto di vista filosofico, è ineliminabile: come hanno spesso ricordato i suoi sostenitori, qualunque discorso si faccia sulla realtà è perciò stesso un discorso metafisico, o dalle implicazioni metafisiche.
I grandi maestri della Cattolica di Milano hanno evidenziato, al proposito, che la metafisica non concerne, come pensava Kant, innanzitutto o esclusivamente l'invisibile, l'al-di-là, bensì l'essere (in tutta la sua estensione: visibile e invisibile),cioè la realtà.
Certo si tratta della realtà nei suoi aspetti più universali e, per così dire, profondi; ma ciò significa precisamente la realtà in quanto realtà (ciò che vi è di più comune, quotidiano, oggettivamente stringente ed ineliminabile).
Se ne doveva rendere ben conto uno dei più accesi nemici della metafisica nel nostro secolo, Otto von Neurath, esponente di spicco del Wiener Kreis, che si era proposto di «liberare» completamente il linguaggio da ogni residuo metafisico. Per raggiungere tale scopo, nel corso delle riunioni del Circolo neopositivista, egli era perciò costretto ad interrompere così spesso i discorsi dei suoi colleghi, che a un certo punto dovette convenire che era molto più semplice intervenire nei ben più rari momenti, in cui non si facevano discorsi dalle implicazioni metafisiche [5].
Sono insomma a tutt'oggi pienamente valide le argomentazioni di Aristotele contro gli antimetafisici, svolte nel libro IV della Metafisica: per p. 110 negare il principio di non-contraddizione (cioè per non riferirsi alla realtà in sé, per non fare metafisica) bisognerebbe non pensare e non parlare, bisognerebbe essere omoios phyto, come un tronco, che si limita a vegetare.
b. Aggiungiamo, da un punto di vista teologico, che la metafisica non significa affatto superba pretesa di possedere razionalmente la chiave interpretativa ultima del reale: da un lato, infatti, una metafisica autentica non può non riconoscersi incapace di spiegare fino in fondo il senso della realtà, e dunque non può non accettare di subordinarsi alla fede e alla teologia; dall’altro il culmine di una metafisica autentica è il riconoscimento di Dio quale Fonte e Significato dell’essere finito, e quindi l’atteggiamento che essa tende a generare è quello della umiltà e della dipendenza, piuttosto che quello di una orgogliosa autosufficienza.
È vero che non sempre le metafisiche storicamente datesi hanno risposto a questi requisiti, basti pensare a Cartesio, Spinoza, Leibniz, Hegel. Si può però facilmente ribattere che non si trattava di metafisiche autentiche, svolte correttamente [6].
Non ogni scientia in verità inflat: il problema non è rifiutare questo tipo di sapienza, ma collocarla al suo giusto posto, che è di subordinazione alla sapienza rivelata (lo stesso von Balthasar del resto diceva,in Teologia 1: «senza filosofia; nessuna teologia valida»).
Il momento filosofico è certo un momento astratto, mentre quello della fede (e della vera teologia) è un momento concreto; potremmo dire che l'uno sta all’altro come una carta topografica sta ad un paesaggio reale. Quello che conta davvero sono i campi, le strade, le persone che vi si incontrano (cioè il concreto), il che però non toglie che una sua funzione, per certi aspetti indispensabile, l’abbia anche la cartina.
Possiamo dunque assumere che la metafisica (la protologia, come sarebbe meno equivoco dire) sia in sé stessa legittima e in qualche modo necessaria. Occorre ora spiegare in che senso costituisca un tassello funzionale alla nostra ricognizione.p. 111
La contemplazione nel concreto è infatti essenzialmente volta al Cristo e alla Sua presenza nella singolarità della concretezza cosmico-storica:che cosa c'entrano allora le strutture generali dell'essere? Si potrebbe così obiettare che se ne può tranquillamente prescindere. Se ne può prescindere certamente de facto: ciò di cui stiamo parlando è stato ed è benissimo vissuto in modo irriflesso, senza giustificazioni concettuali. Del resto chi scrive è stato spinto a riflettere su questo argomento non solo e non tanto per degli stimoli avuti da libri, quanto innanzitutto per aver visto delle umanità e delle situazioni (cristofaniche). Ho visto dei volti diventare luminosi, belli. Di una bellezza non «categoriale», innata, quantitativa (nel senso di armonia di parti: le «integritas» e «debita proportio» tomistiche), ma «trascendentale», acquisita (eppur rivelativa del loro «mas profundo cientro», per dirla con S. Giovanni della Croce), «sostanziale» (nel senso, tomistico, di «claritas» come emergere glorioso della propria formainteriore). Una tale bellezza mi è appunto parsa epifanica di quel Centro, di quella Presenza, che tali persone lasciavano crescere in sé. Questo è dunque il fatto. Che è poi ciò che più importa. E tuttavia quando ci si mette a riflettere, come pure è giusto fare, non si può, de jure, sorvolare sul livello ontologico del reale. Sarebbe fideistico,poiché negherebbe all’Evento cristiano il suo spessore totale, che include una «presa» sull’ambito naturale [7]. Del resto metafisica e contemplazione si implicano vicendevolmente: l'atteggiamento contemplativo non comporta infatti un’inebetita estraneazione, ma al contrario (quando è vero) richiede la fuoriuscita da quell’«efficiente sonnambulismo razionale» 112 in cui normalmente siamo immersi p. 112 (come osserva Eliot in Assassinio nella cattedrale «il genere umano non può sopportare molta realtà»); l’attivista si inganna (tutti noi ci inganniamo) credendo di essere concreto:in realtà, come già notava Lucrezio («hoc se quisque modo...») si affanna a fuggire dal reale. Essere immersi nella realtà implica accettarla, non averne paura, dunque guardarla in faccia senza diaframmi e senza progetti,cioè, appunto, contemplare. Ora,se la metafisica è la scienza della realtà in quanto realtà, e se la contemplazione è l’unico atteggiamento che riconosca, accetti ed ami la realtà della realtà, riconciliandoci con essa, si vede bene che tra i due termini vi è una totale consonanza: una contemplazione che rigettasse in linea di principio la metafisica sarebbe una evasione[8].
2. L'apertura all'essere
Per quanto già detto sopra noi non toccheremo tutti i passaggi della metafisica, ma ci soffermeremo su alcune questioni, che hanno diretto rapporto con il tema della contemplazione nel concreto. La prima di tali questioni è senza dubbio quella del«primum cognitum», secondo la denominazione classica nella Scolastica: qual è l'oggetto primordiale, originario, in qualche modo onniavvolgente della nostra conoscenza? p. 113
È noto che la filosofia moderna, almeno nella sua corrente egemone, che Bontadini soleva definire gnoseologistica (peraltro non solo in senso spregiativo), ha dato una risposta di tipo dualistico: non si conosce la realtà in sé, ma la nostra soggettiva - nel senso di soggettivistica - rappresentazione di essa; non si conoscono le cose, la realtà, ma le nostre idee. In età postkantiana, si sa, le cose non cambiano, se non per peggiorare, dal momento che al soggetto si attribuisce un potere creatore nei confronti dell'oggetto. Il che è più evidente nel caso dell’idealismo, ma non è meno vero anche nel caso della maggior parte delle altre filosofie contemporanee, a partire dal marxismo, per il quale la verità non c'è, ma va fatta (dalla prassi rivoluzionaria).
Dovrebbe essere evidente che simile impostazione non è compatibile conl’idea di contemplazione nel concreto. Nel caso del dualismo moderno anzitutto per il fatto che in esso non si può dare alcuna rivelatività, alcuna epifanicità del concreto (che è invece elemento essenziale per l'idea in questione). Esso infatti implica una opacità, un velarsi intrascendibile dell’essere. Non si limita a dire che la nostra conoscenza del reale sarebbe imperfetta (come ben sapeva il pensiero cristiano medioevale): dice, assai più radicalmente, che la realtà finita (il cosmo, l’uomo, la vita, la storia) è irraggiungibile alla conoscenza umana. Se dunque il finito non può essere colto in sé stesso, a maggior ragione non potrà essere manifestativo, epifanico, di Altro.
A sua volta l’antropocentrismo assoluto della filosofia contemporanea prevalente è agli antipodi di un atteggiamento contemplativo, come ci pare evidente, e come peraltro abbiamo già altrove ricordato [10].p. 114
Sgombrato il campo dall’antirealismo gnoseologistico, possiamo quindi affermare che la contemplazione nel concreto presuppone come sua base metafisica l'apertura conoscitiva al reale, all’essere. Su tale asserzione vanno però subito operate ulteriori precisazioni: a. si tratta infatti di chiarire che cosa sia quel reale,che ci si dà quale «primum cognitum» (ex parte obiecti); b. e si tratta altresì di puntualizzare la modalità conoscitiva originaria in cui esso viene colto (ex parte subiecti).
a. È opportuno anzitutto chiedersi se il «primum cognitum» sia lo stesso Cristo, Verbo di Dio. È noto ad esempio che nel suo Factum est Testori pone in bocca al bambino ancora nell’utero il nome, seppur biascicato e stravolto, di Gesù Cristo: ardita e coraggiosa trasposizione letteraria di una convinzione che era stata di molti Padri della Chiesa [11] e che ha come fondamento il Prologo del Vangelo di Giovanni. Se infatti tutto ciò che è stato fatto (tutto ciò che esiste), è stato fatto per mezzo del (nel) Verbo, del medesimo Verbo tutto parla. Non è d’altro lato dogmaticamente vero che nella Pienezza finale il Cristo apparirà per quello che già ora è (benché solo in qualche modo, data la presenza del male), ossia la Consistenza, il Centro, e per così dire la Sostanza di tutto ciò che esiste?
Ciò nondimeno non possiamo affermare simpliciter che il Verbo sia il «primum cognitum». Vale a questo riguardo quanto S.Tommaso precisava circa la conoscenza immediata di Dio (S. Th. I, q 2, al): una cosa è vedere venire uno (che di fatto è Pietro), altra cosa è sapere che quello che viene è Pietro. Solo in questo secondo caso si ha un riconoscimento esplicito.
Oggettivamente, nel suo più profondo costitutivo «la realtà è Cristo» (S.Paolo), ha la sua consistenza in Cristo; ma l’uomo, in virtù delle sue facoltà conoscitive naturali, non lo può sapere.
Diremo allora, con la gran parte della tradizione scolastica, che il «primum cognitum» è l'essere degli enti finiti (ciò dicendo,notiamolo en passant, restiamo al di qua della distinzione tra interiorità ed esteriorità, spirito e natura). A questo punto però dobbiamo scegliere per una delle tre vie che ci si presentano: o il «primum cognitum» è l’esserci degli enti percepiti qui ed ora (flessione empiristica: l'orizzonte originario e intrascendibile del conoscere è la mutevolezza frammentaria dell’istante); o esso abbraccia immediatamente la totalità del reale, l'essere, visto come p. 115 un monolite concreto, reificato (versione estrema: Parmenide; versioni attenuate: gli spiritualismi); ovvero si coglie negli enti attualmente percepiti (in questo cielo azzurro scuro, con nembi bianchi e ombrati,in questo tavolo e in queste persone) l'essere,non quale effimero esserci, contingente e casuale, ma neppure quale massiccia e compatta res, bensì come presenza onnipermeante.
Nel primo caso l’unità verrebbe sacrificata alla molteplicità, nel secondo sarebbe questa ad essere svuotata dall'unità. Soltanto la terza impostazione salvaguarda e sintetizza i due poli suddetti. Che cosa significa allora questa α) apertura all’essere (totale) β) attraverso l'immediatezza degli enti (particolari)?
Significa che α) da un lato noi percepiamo che la realtà esiste non in modo effimero, scivoloso, risucchiabile nel nulla; bensì come una presenza stabile, imponente, inattaccabile [12]. La realtà resiste, tiene duro (il suo Centro non ha «sottratto la sua guancia agli sputi,il suo dorso ai flagellatori»): l'essere è, in tutta la sua rocciosa permanenza, la sua densa necessità, la sua universale ampiezza. Non è infatti da noi conosciuto come limitato all’attuale campo percettivo: potremmo anche non esserci mai mossi da questo luogo, e non avere alcuna nozione di geografia e di astronomia, ma avremmo comunque la certezza che le leggi fondamentali dell’essere sono vere in sé e quindi non solo per questi enti, che ora vedo, ma per qualunque ente esista. β) D'altro lato questo orizzonte totale non lo conosciamo se non dentro un dato presente, immediato. Secondo la tesi comune dei filosofi cristiani noi non disponiamo di una intuizione intellettuale separata, o indipendente,dalla intuizione sensibile, e tale perciò da attingere l’essere senza la mediazione degli enti. Questo non significa minimamente attutire la precedente asserzione, ma può piuttosto richiamare al bisogno di alimentare continuamente il nostro approccio al reale dentro la concretezza particolare (degli enti nella loro singolarità).
b. E siamo così introdotti al versante soggettivo della questione: la conoscenza originaria dell'essere, se quanto abbiamo finora detto è vero, p. 116 non sarà né una pura registrazione del dato immediato, effettuata principalmente dai sensi (so che questi enti sensibili in questo momento sono, e sono identici a se stessi), con l’intelligenza appiattita in un compito di passiva subordinazione, né una intuizione del puro pensiero(come oggi vorrebbe Severino), che ergendosi sdegnoso sopra la mutevole molteplicità degli enti sensibili, si fisserebbe su un essere perfettamente attuale e unitario (so che l’essere è e non può non essere... se non pura e compatta attualità).
Si tratta invece di una sinergia sensitivo-intellettiva, di una cooperazione intrinseca tra l’energia sensoriale, impegnata a cogliere gli oggetti ora presenti, e l’energia intelligenziale, protesa ad intus-legere, a leggere dentro il sensibile, l’ampiezza totale (seppur non dettagliata) dell’essere e delle sue leggi [13].
Come quanto abbiamo detto in questo paragrafo si attagli alla idea di contemplazione nel concreto, ci pare abbastanza ovvio: essa presuppone infatti la possibilità che l’Intero si dia a conoscere dentro un particolare, per cui a partire da un singolare concreto si apra uno squarcio sulla Totalità. E tale struttura si ripropone analogicamente per quanto riguarda l’essere, colto in tutta la sua estensione e necessità, a partire da degli enti particolari.
Un'ulteriore precisazione andrebbe fatta sul ruolo della libertà nel riconoscimento della evidenza dell’essere: un tema molto sviluppato, nel p. 117 nostro secolo, dal Blondel. Qui dobbiamo almeno accennare al fatto che se l'intervento della volontà fosse determinante, non si potrebbe più parlare di evidenza, e tutta l’umana conoscenza sarebbe sospesa ad una opzione del tutto arbitraria [14].
3. Il volto dell'essere
Finora abbiamo visto che si dà una apertura all’essere (totale), dentro gli enti; dobbiamo ora vedere come l’essere possa parlare, a) negli enti b) dell’Unico. A quali condizioni metafisiche cioè sia possibile dire, come Jacopone da Todi, che dell'Amore «onne cosa clama», con l'Imitazione di Cristo che «Unum omnia loquuntur, o ancora, con Giovanni della Croce che «todos cuantos vagan/de Ti me van mil gracias refiriendo» (Cant. espir.).
I. Forse ci si aspetterebbe, a questo punto, un discorso sulle prove dell’esistenza di Dio. Ma ci pare che esso sarebbe ridondante: è infatti fin troppo ovvio che una metafisica che si attagli all’idea di contemplazione nel concreto preveda la possibilità di tali prove. Si sa, d'altro canto, che i pensatori cattolici divergono sull'importanza da attribuire, esistenzialmente ma anche culturalmente, a tali dimostrazioni: accanto a quelli che ne sottolineano l’imprescindibile valore, e pertanto operano grandi sforzi in vista di una loro sempre maggior rigorizzazione (pensiamo a S. Tommaso,e nel nostro secolo a Bontadini, Garrigou-Lagrange, Maritain, Fabro, Seifert), vi sono coloro che sottolineano la decisività di un incontro esperienziale con quell’Evento cristiano, che nel tempo persuade l’uomo p. 118 tanto della esistenza di Dio, quanto della Divinità del Cristo. Non è che questi ultimi, tra cui potremmo annoverare, nel passato S. Agostino o S.Bonaventura, oggi de Lubac o von Balthasar, neghino la possibilità e nemmeno l’utilità di una prova razionale; ma non le annettono una importanza decisiva, né vi dedicano particolari cure di affinamento «tecnico», anche perché è loro comune convinzione che un certo grado di conoscenza di Dio sia facilmente attingibile da chiunque [15].
Noi, pur senza escludere la prima prospettiva, assumiamo almeno provvisoriamente la seconda, e perciò non ci soffermiamo su questa parte del discorso metafisico.
2. Il tema più nodale ci pare quello che una ininterrotta tradizione filosofica chiama analogia. Si tratta cioè di discernere come si compongano, nella totalità del reale, unità e molteplicità, identità e differenza.
Si può subito cominciare con l’eliminare le ali estreme: né la pura unità dell'essere parmenideo, né il suo totale sbriciolamento nella molteplicità (in età antica: gli atomisti e Anassagora, in età moderna gli empiristi e in qualche modo il neopositivismo), sono compatibili non solo con la contemplazione nel concreto, ma neppure con una visione cristiana della realtà. Ma focalizzando meglio dovremmo elidere, o piuttosto correggere e integrare, anche le impostazioni metafisiche di Platone e Aristotele: il primo in quanto non riconosce una piena dignità al molteplice,il secondo per il suo risolvere (il senso del)l'essere nelle sostanze, concepite come impermeabilmente circoscritte, il che lascia molto sullo sfondo il carattere unitario del reale [16].
Possiamo trovare del materiale utile perciò che cerchiamo soprattutto nelle sintesi scolastiche (si badi: dicendo «del materiale utile» intendiamo escludere che si possa installarsi in tali costruzioni, facendone un assoluto p. 119 e ignorando o condannando in blocco il pensiero successivo e, soprattutto, le urgenze specifiche del nostro tempo),in particolare in Tommaso e in Scoto [17].
Il loro pensiero metafisico si è (almeno oggettivamente) giovato della conoscenza del Mistero Trinitario: Dio, la Pienezza e l’Origine dell'essere è al tempo stesso uno e trino (molteplice, se così possiamo dire); o anche della struttura (insopprimibilmente bipolare) personale-comunionale dell’uomo. Così sarà, analogicamente, del reale finito: in esso si comporranno i due poli di unità e molteplicità, in una tensione dialettica che non sacrifica nessuno dei due [18]p. 120.
Da un lato esiste una molteplicità di enti, che con Aristotele la filosofia medioevale ha chiamato sostanze: il reale che ci è dato non è un ammasso caotico, uno sciame nebulosamente lattiginoso, indistinto e confuso; si coagula intorno a centri di convergenza, che ne fanno un ordine in qualche modo policentrico [19].
Ogni ente sostanziale, ognuno di questi nodi dell’essere, ha una sua natura, una essenza, che lo racchiude e lo delimita in un perimetro circoscritto, conferendogli una caratteristica di non-confondibilità (un atomo di cesio non è un atomo di uranio, un leopardo non è un leone). Ogni ente è così «indivisum in se», forte di una sua consistente identità specifica, e «divisum a quolibet alio»; se ne sta tranquillo (perché internamente uno) nella sua stabile e circoscritta essenza: ogni cosa è se stessa.
Tra i due grandi dottori medioevali ad insistere su questo polo è stato indubbiamente S. Tommaso, che ha attribuito alle molteplici sostanze create una particolare «forza», ad esempio con la sua dottrina della unicità della forma sostanziale e anche con il suo discorso sull’esse ut actus [20].
Ma vi è, d'altro lato, anche il polo della unità dell’essere: in primo luogo per il fatto che le cose mutano, trapassando l'una nell’altra, e varcando p. 121 confini che sembravano invalicabili (la ciliegia era identica a sé, in modo apparentemente perentorio e inappellabile, ora invece che l'ho mangiata essa si è assimilata al mio organismo; ma il mio corpo stesso non è forse composto da atomi di materia, che un giorno furono in alberi, o fiumi, o in elementi astrali?).
In secondo luogo perché anche nel medesimo istante le cose non sono degli atomi senza relazioni,bensì formano una sorta di sinfonia cosmica, una rete fittissima di rapporti e di influenze reciproche.
Ecco allora che occorre completare la precedente affermazione con la sua (polarmente) opposta:ogni ente è - anche- «unitum cum quolibet alio», rapportandosi agli altri enti in modo non estrinseco, ma vitalmente necessario, nutrendoli ed essendone nutrito. Similmente si dovrebbe dire di ogni ente che è - anche - «divisum in se»: la sua identità con se stesso non è statica, tranquilla, esso è uno di una unità in certo modo dialettica (aspetto di parziale verità dell’hegelismo, e di Eraclito). Vi è in ogni soggetto sostanziale una tensione polare, per dirla con Guardini, una specie di inquietudine costitutiva [21]. Che gli è insita per il fatto di essere un frammento, e non la Totalità, che sola riposa in ses tessa(«nel quieto mare del suo stesso Amore»). E che lo proietta nella rete dei rapporti universali.
Tutti gli enti finiti possono così essere visti come partecipi di una universale comunione (sobornost), in cui pur sussistendo dei contorni e dei confini precisi, esiste non meno forte un legame ed una armonia, un rinvio reciproco e una reciproca appartenenza [22]; il loro essere non è solo p. 122 il loro (esclusivamente proprio) essere, la perfezione ultima ed incomunicabile dell’esse ut actus, ma è anche riverbero, partecipazione di un comune; che è come dire che l’essere non è solo il quo (quidquid est est), ma èanche il quod (est, ubicumque aliquid est); o, metaforicamente, non vi è solo l'aspetto montano di una vetta che si staglia con nitore splendente di ben determinati contorni (sottolineatura tomistica: esse ut actus), ma anche l'aspetto marino, di indistinta immersione in una medesimezza che accomuna.
Questo secondo polo è stato maggiormente evidenziato dalla Scuola francescana in generale e da Scoto in particolare: basti pensare alla sua nota tesi della univocità dell’essere, che gli permette non solo di erigere un solido contrafforte verso l’agnosticismo, ma anche di riannodare sinteticamente intorno al Verbo tutti gli enti creati [23].
Vediamo ora di esplicitare come questa impostazione sia consona all’idea di cui trattiamo. Occorre innanzitutto che tra gli enti, che formano il mondo creato, esista una fondamentale unità affinché possano parlare del Medesimo Verbo. Delle sostanze concepite cartesianamente, o forse anche aristotelicamente (di un aristotelismo non riplasmato) come centri impermeabilmente autonomi ed autosufficienti non potrebbero prestarsi p. 123 a riverberare in sé i raggi di un Altro; la dimensione simbolica, il rinvio intrinseco ad altro,per dirla in altri termini, risulterebbe impossibile o gravemente compromesso [24].
D'altro lato è pure necessario che l’unico Significato ci raggiunga, si manifesti, non sorvolando né svuotando il livello naturale della non illusoria molteplicità degli enti. Il Verbo divino infatti, che è il centro della contemplazione nel concreto, ha assunto la natura umana, accettandone fino in fondo i limiti e le leggi (e sottostando parimenti ai limiti e alle leggi della natura creata tutta). Pretendere di saltare a pie’ pari questo livello sarebbe dunque distogliere lo sguardo dalla modalità effettiva di automanifestazione di Dio riducendo la contemplazione a oasi spiritualistica.
E quindi necessario che gli enti abbiano un loro (proprio e inconfondibile) essere.
3. Un'ulteriore, ed ultima, aggiunta: finora infatti abbiamo elencato delle condizioni metafisiche, che garantirebbero una contemplazione nel finito, nelle sue strutture essenziali, generiche. Ma la contemplazione nel concreto riguarda il finito nella sua singolarità: non basta che il tramonto in generale mi richiami alla riappacificazione escatologica di tutte le cose, nel Sabato eterno, occorre che questo unico e irripetibile tramonto mi dica qualcosa dell’Eterno, dell'eterna Pace, lo dica a me per quello che io sono ora, con i problemi e le aspettative che si addensano in modo irripetibile in questo frangente.
Il problema metafisico che qui si pone è allora quello del principium individuationis: che cosa fa sì che queste realtà particolari, che entrano nel mio orizzonte percettivo, siano proprio queste (uniche ed inconfondibili)? Quale fattore determina, quale principio metafisico garantisce la loro singolarità?
Una volta che si sia ammesso, come abbiamo visto essere necessario fare,il carattere policentrico del reale, il suo ramificarsi in una molteplicità di centri sostanziali, dovremo di conseguenza ammettere, per salvare l’oggettività della percezione sensibile, che ci attesta un mutamento pressoché continuo negli enti, la distinzione tra un nucleo sostanziale e delle «irradiazioni» e determinazioni accidentali. Ora però non si potrà p. 124 attribuire agli aspetti accidentali il compito di individuare un soggetto sostanziale [25]. Si dovrà perciò ricorrere ai costitutivi intimi del nucleo sostanziale, il principio materiale e quello formale: è noto che Tommaso attribuisce al primo (alla «materia signata quantitate») il compito di individuare un dato ente, mentre Scoto ricorre alla «haecceitas», che è un sigillo ultimo di tipo formale.
Per quanto concerne il nostro discorso non sembra che la soluzione tomista garantisca appieno il valore della singolarità inquanto tale: la materia (in senso scolastico) è un fattore totalmente indifferenziato ed indistinto,e affidare ad essa l'onere di differenziare appare insufficiente e problematico, come è stato più volte ribadito da molti studiosi. La soluzione scotista sembra maggiormente adatta, in quanto dà piena dignità filosofica al singolare, al concreto, rendendo così perfettamente verosimile che l’Infinito scelga di rendersi presente, contemplabile in esso [26]: il Verbo di Dio si è fatto uno dei miliardi di esseri umani, uno tra i tanti che si sono succeduti sulla faccia della Terra; ed ha incontrato non l’umanità in generale, ma delle persone concrete piuttosto che altre (Sua Madre, S.Giuseppe, i compaesani di Nazaret, i dodici apostoli, alcuni tra quanti si trovavanoin Palestina nei primi decenni della nostra era). E anche nel modo di rendersi presente alle generazioni successive vige il principio della elezione: la redenzione di Cristo raggiunge gli uomini non attraverso la diluita universalità di una grazia «anonima» (Rahner), ma tramite la «concentrata» singolarità concreta di un «piccolo gregge». Occorre quindi p. 125 cercare una fondazione metafisica adeguata a questa decisiva importanza del concreto, quale non ci pare, lo ripetiamo, la soluzione della materia signata quantitate, che di fatto consacra il primato della generalità [27]; mentre nella haecceitas troviamo del materiale più utile per esprimere filosoficamente il valore cristiano della singolarità e per fondare teoreticamente la possibilità di una contemplazione nel concreto. p. 126
Francesco Bertoldi (1958) è laureato in filosofia presso l’Università Cattolica di Milano, con una tesi sulla modernità in Henri de Lubac. Insegna filosofia nelle scuole superiori.
note
[1] Contemplazione e cosmologia, in Communio n.108 (1989), pp. 66-83.
[2] Chiariamo che facciamo ciò non certo per disprezzo nei confronti di una impostazione «puramente teoretica» della metafisica, ma molto più semplicemente perché è richiesto dalla presente economia del discorso. È poi evidente che le linee di metafisica, che emergeranno come confacentesi alla contemplazione nel concreto, noi le riteniamo, al tempo stesso, vere in senso assoluto (e non solo in quanto implicate da tale idea). D'altro lato è anche giusto aggiungere che esistenzialmente parlando, la certezza fondamentale non concerne qualsivoglia tesi o verità “puramente teoretica”, bensì il vissuto, nel quale rientra, come diremo poi, la contemplazione nel concreto.
[3] Alludiamo ad esempio alla mentalità che si esprimeva in slogans del tipo “dopo Freud...” o “dopo Marx...”, veri condensati di ignoranza, intolleranza e livellamento verso il basso della cultura.
[4] Citiamo ad esempio la riedizione del lavoro di Edith Stein, Essere finito ed Essere eterno, tr.it. Città Nuova, Roma 1988; i recenti Essere e persona di Josef Seifert e Essere e parola di Virgilio Melchiorre, entrambi editi da Vita e Pensiero, rispettivamente 1989 e 1990, nella collana, essa stessa significativa,”Metafisica e storia della metafisica”. Significativo anche il contributo di Giuseppe Colombo (da non confondersi con l'omonimo teologo) sulle prove dell’esistenza di Dio: Conoscenza di Dio e antropologia, ed.Massimo 1988 (un’altra editrice che sta contribuendo in misura rilevante alla rinascita della metafisica.
[5] L’aneddoto è raccontato dalla stessa seconda moglie di von Neurath.
[6] Una seria riflessione metafisica è tutt'altro che fonte di superbia e di lontananza dalla realtà concreta: valga per tutti l'esempio di Edith Stein, contemplativa e metafisica. Questo problema è stato risollevato nel corso di una recente polemica, sulle pagine di Sapienza, tra fautori e avversari della metafisica in ambito cristiano, ed è ricorsa ancora una volta l’accusa che la metafisica sarebbe nociva all’umiltà e alla fede: si tratta di una preoccupazione che andrebbe indirizzata non tanto alla metafisica in sé, quanto all’errato atteggiamento di alcuni suoi cultori.
[7] Cfr. 14. V.von Balthasar, Gloria I, Jaca Book, p. 20: «non è da nutrire eccessiva speranza che questi occhi nuovi ci siano comunicati e ci vengano aperti, se prima non abbiamo già imparato a contemplare con gli occhi vecchi la forma dell’essere. La soprannatura non serve a sostituire ciò in cui siamo falliti con le nostre capacità naturali.(...) Gli stessi secoli della cristianità (...) seppero magistralmente comprendere il linguaggio della forma del mondo naturale». Cfr. anche, ivi, pp. 131/2. E in Verità nel mondo, vol. 1 di Teologica (Jaca Book, Milano 1989), p. 19: la «verità filosofica - anche a prescindere dalla luce teologica- è in sé stessa assai più ricca di quanto lascino supporre molte sue esposizioni. (...) l’opera della grazia (...) ha bisogno di tutta la pienezza - del regno naturale - per rappresentarsi (...). Se si trascura questo previo lavoro filosofico, ne patisce soprattutto la teologia».
[8] L. Lombardi Vallauri, Terre, Vita e Pensiero, Milano 1989, p. 420. Interessanti osservazioni sulla contemplazione in altre parti del libro,in particolare nel cap.17. Molto giustamente l’autore distingue l'improvvisa illuminazione tipicamente contemplativa, che apre al reale, risvegliandoci ad esso, dalla scoperta dello scienziato, che può restare nella astratta (falsamente concreta) ragnatela delle nozioni.
[9] Non è una bizzarria filosofica, ma un dato di comune esperienza: il peccato non implica forse una messa-tra-parentesi della realtà? Ricorrente, ad esempio, in vari episodi dei Racconti della tavola rotonda è il tema della tentazione come inganno, illusorio distoglimento dalla realtà, per cui il suo superamento comporta un immediato risveglio ad una visione realistica delle cose (cfr. ne “La ricerca del santo Graal”, i capp. 8° e 15°). La sanità, anche psicologica, non implica la capacità di guardare intensamente (ma senza l’affannoso sforzo di chi deve preoccuparsi di se stesso,essendo ripiegato su di sé) il reale, senza diaframmi, accettandolo senza pretendere di incapsularlo in un progetto? Che il reale sia è tremendo e bello al tempo stesso: accettarlo comporta immediatamente un atteggiamento religioso. Una divertente trascrizione letteraria degli effetti deleteri dell’antirealismo si può ad esempio trovare nel personaggio di Mister Hibbs “comunque”, ne L'osteria volante di Chesterton (si veda anche “Il treno ha fischiato”... di Pirandello).
[10] Nel nostro precedente articolo, “Contemplazione e cosmologia”, cit. (nota 1). Possiamo qui aggiungere che non ci pare da un lato che il pensiero “gnoseologistico” moderno-contemporaneo sia da rigettare in blocco. Come hanno riconosciuto gli stessi esponenti più in vista della filosofia cattolica del nostro secolo, si tratta di una parabola che ha maturato la cultura filosofica. D'altro lato però non è neppure negabile che, esistenzialmente, l’antirealismo sia la cristallizzazione teorica di un annebbiamento della consapevolezza, direttamente proporzionale al peccato. Tutta la tradizione spirituale cristiana lo insegna: dal Vangelo di Giovanni, che relaziona la tenebra con la mancanza di carità, a S.Benedetto, che descrive la conversione in termini di risveglio (cioè di presa di coscienza del reale),a S.Giovanni della Croce, che ricorda come gli “appetiti” intorbidino e oscurino l’anima. D'altronde, anche in ambito letterario le citazioni, che si potrebbero fare, occuperebbero l’intero articolo: limitiamoci perciò al bellissimo passo del Macbeth (V,5), in cui la sensazione che tutto svanisca in una favola irreale consegue la malvagità di Macbeth.
[11] H.U. von Balthasar, Liturgia cosmica, ed. AVE, Roma 1976.
[12] Cfr. H.U. von Balthasar, Verità del mondo, cit., p. 42: «il conoscente sa, quando conosce l’essere, che ha davanti a sé l’ultimo soggetto di tutti i possibili predicati e che dunque (..) fondamentalmente nulla sfugge alla sua conoscenza, nel senso che almeno è essere.(...) quindi non c’è da temere un qualche sfondo ignoto alle spalle dell'essere (...). Dove c'è emeth, ci si può lasciar andare,ci si può affidare».
[13] A questo punto occorrerebbe affrontare il discorso delle due leggi fondamentali dell’essere, il principio di identità e il principio di non-contraddizione, sul cui rapporto di sequenzialità c'è disaccordo tra filosofi cristiani; ma dobbiamo limitarci ad un rapido cenno (la questione viene ampiamente tematizzata negli scritti di Bontadini, a cui perciò rimandiamo per approfondimenti). Diciamo allora che il principio di identità, che esprime la circoscritta ed immediata identità dell'ente è più legato alla prima sottolineatura, mentre il principio di non-contraddizione, che staglia l’identità sullo sfondo della non-identità (e ultimamente della totalità dell'essere) è più consono alla seconda. Non a caso al principio di identità, analitico e circoscrittivo, attribuiscono il primato pensatori come Maritain e la Vanni Rovighi, mentre Bontadini privilegia il principio di non-contraddizione, sintetico-totalizzante. Se è vero che occorre sintetizzare le due polarità sarà forse più corretto parlare di una circolarità che di un primato. Un corollario metodologico di ciò è che da un lato ogni cosa è intelligibile in se stessa, nella sua recisa e analitica identità; d’altro lato, in quanto essa si staglia su uno sfondo, sullo sfondo della alterità, per capirla fino in fondo occorre capire la sua non ovvietà, cioè opporla al suo contrario.
[14] E quanto padre Garrigou-Lagrange, paladino del tomismo nella prima metà del secolo, rimproverava al filosofo francese: se non fosse incontrovertibilmente evidente l’oggettività dell'essere e delle sue leggi fondamentali, non vi sarebbe nessuna ragionevolezza nella stessa adesione di fede. L'opzione è decisiva appunto a questo secondo livello, che non può però essere confuso con il primo, quello di un approccio naturale (proprio della ragione naturale) al reale, che si impone come non-contraddittorio. Tuttavia è vero (come sosteneva Blondel) che i due livelli non sono separabili, e che esistenzialmente rifiutare il Mistero di Cristo implica rifiutare (=fare il possibile per ottundere, senza mai poter cancellare) l'evidenza dell'essere e delle sue leggi. In questo senso, esistenzialmente e di fatto, l'apertura “metafisica”, il riconoscimento del reale nella sua verità richiede un atteggiamento di lealtà,di “buona” volontà (come diceva Bontadini è una questione di “tipo umano”).
[15] Decisivo sarà piuttosto l'atteggiamento della volontà, il “cuore”, piuttosto che l'elaborazione concettuale. Può una dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio aiutare a credere? O è forse controproducente? Abbiamo già ricordato che il dibattito su questi temi è più che mai aperto nel mondo intellettuale cattolico odierno. Certamente la fede non è generata dalla metafisica, ma da un incontro; d’altra parte se una metafisica è ben condotta, come già sopra dicevamo, non può sicuramente nuocere. ‘Tra questi due “argini” esterni ci può stare una variegata gamma di opzioni, che bisognerebbe esaminare caso per caso.
[16] Non per nulla non sarà certo Aristotele, ma la Scolastica ad elaborare una compiuta dottrina dei trascendentali.
[17] Per quanto concerne Scoto immaginiamo che qualche lettore non sarà daccordo nel collocarlo a fianco di S.Tommaso: per il vecchio pregiudizio, che vede nel Doctor subtilis l'inizio della crisi della Scolastica e il precursore di Occam. Ma di pregiudizio si tratta, dato che il pensiero del grande francescano, quale emerge dalla recente editio critica vaticana, è perfettamente ortodosso, e per nulla corrosivo. All’origine di tanta incomprensione sta da un lato una oggettiva difficoltà alla verifica dell’autenticità dei suoi testi; dall’altro il clima, imperante per tutta la prima metà del nostro secolo, di ferrea egemonia teologica del tomismo, che ha portato a considerare con sospetto gli altri indirizzi. Cfr.A.Poppi, Classicità del pensiero filosofico di Duns Scoto, in Classicità del pensiero medioevale, Vita e Pensiero, Milano 1988, pp. 83/120 (si veda anche sotto, la nota 23). Decisamente strano in questa prospettiva è il giudizio di von Balthasar su Scoto (Nello spazio della metafisica. L'età moderna, vol.V di Gloria, pp. 25/8), visto come momento negativo nella storia della teologia; tanto più strano se lo si confronta con quanto lo stesso von Balthasar dice a proposito di un autore incondizionatamente apprezzato come Hopkins, la cui dipendenza da Scoto viene riconosciuta e tematizzata in chiave positiva (Stili laicali). Più ingenerale ci pare che solo una “distrazione”, dovuta probabilmente al pregiudizio di cui sopra, assimilato negli anni della sua formazione (in particolare grazie alle tesi del Siewerth), abbia impedito al teologo svizzero di cogliere la profonda consonanza del Subtilis con la sua impostazione.
[18] Esistono oggi, in campo teologico cattolico,delle obiezioni piuttosto serie al tomismo (accanto peraltro ad una ripresa della filosofia tomista, che ci pare sorprendente, se si pensa a quel recente passato, che lasciava pensare ad una rapida estinzione di tale indirizzo intellettuale); in particolare qui pensiamo alla accusa di “sostanzialismo”, un sostanzialismo reificante, le cui conseguenze si farebbero poi sentire a livello etico e sacramentale, con uno squilibrio a favore dell’elemento oggettivo-cosale sul fattore consapevolezza/intenzionalità soggettive (cfr. ad es.J.Tischner, “Il declino del cristianesimo tomista”, in Metodi del pensare umano, ed.CSEO, Bologna 1982, p. 40-45 in particolare). Non possiamo qui entrare nel merito di possibili implicazioni erronee in campo teologico (che potrebbero peraltro essere del tutto sganciate da un impianto “sostanzialistico”), ma ci pare vada detto che non è possibile rinunciare al concetto di sostanza, senza gravi conseguenze, anche teologiche. Il reale non sarebbe allora (almeno per il pensiero speculativo, o diciamo anche “scientifico”, l’unico insomma che in fin dei conti decide) che una fluida e informe girandola di svolazzanti apparenze, un continuamente cangiante teatro humiano. Una cosa è dire che le sostanze non vanno intese come delle “piccole divinità”, totalmente impermeabili ed autosufficienti (al modo di Cartesio, e più ancora, di Spinoza), altro è negare la loro stessa esistenza.
[19] Non le si vuole chiamare sostanze? Si proponga pure un altro nome, ma il concetto di sostanza, lo ripetiamo, non potrà essere abolito senza cadere o nello sgretolamento polverizzatore di uno Hume o nel monismo non-sostanzialistico dell’idealismo.
[20] È chiaro che la tesi della unicità della forma sostanziale garantisce alle cose, alle realtà finite una unità interiore molto maggiore della tesi, accolta ancora da S.Bonaventura, di una pluralità di forme;e tale maggiore unità significa poi maggior consistenza, maggior autonomia.La concezione dell’esseut actus, che da parte di molti studiosi del nostro secolo è stata vista come l'apporto più originale della metafisica tomista, pur avendo anche altre valenze (=la forza, il primato del reale finito, non in quanto finito, ma in quanto reale, sul pensiero umano, contro Hegel, che esautora l’essere a favore del pensiero) si può qui considerare come l’attribuzione di uno spessore ontologico cospicuo agli enti finiti, ognuno dei quali è intimamente penetrato di un suo unificante e attualizzante actus essendi (=forza dell’essere finito, rispetto all’Infinito). Quest'ultimo aspetto viene per solito trascurato dagli studiosi tomisti, che preferiscono (et pour cause!) concentrare la loro attenzione sulla prima valenza.
[21] Si dovrebbe qui dire qualcosa sul problema del rapporto tra essenza ed esistenza, al cui riguardo Tommaso e Scoto danno soluzioni diverse, ma non opposte. Entrambi infatti escludono tanto una coincidenza tra i due poli (il che avrebbe una implicazione panteistica: la necessità assoluta dell'Essere risiederebbe esaurientemente nelle essenze finite), quanto la riduzione dell’esistenza a mero accidente dell’essenza, al modo di Alfarabi, e in genere secondo l'indole culturale asiatica (per cui il mondo finito svaporerebbe in una danza cosmica, priva di drammaticità). Dentro questo orizzonte comune, i due divergono come sottolineatura: Tommaso, distinguendo maggiormente, tende a salvaguardare l’impalcatura intelligibile delle strutture essenziali universali, laddove Scoto, puntando tutta l’attenzione sulla concretezza singolare di questo mondo (non in quanto mondo, ma in quanto questo) segnato dal peccato e dalla Redenzione, preferisce sfumare la distanza, elaborando, com'è noto, il concetto di distinctio formalis.
[22] Come è stato esplicitato da diversi studi di pensatori contemporanei (spinti,pare, dalla esigenza di recuperare uno sguardo unitario sul reale, di cui la rivalutazione heideggeriana del linguaggio poetico è solo una, parziale e in sé incompleta espressione) il linguaggio metaforico ha qui, nella ontologica parentela, nella oggettiva circuminsessione delle cose, il suo fondamento: cfr. V.Melchiorre, op. cit. (nota 4), pp.44-56 e pp. 166-190.
[23] Esiste come si vede una proporzionalità inversa tra l’unità “interna” ad ogni cosa e l’unità tra le cose: il tomismo, che accentua la prima, attenua la seconda; viceversa Bonaventura e Scoto non attribuiscono alle sostanze create la forte consistenza di una unità interna, per meglio ricomporre l’intero reale intorno al Centro divinoumano del Cristo (“settemplicecentro”, S.Bonav.Ia Coll. in Hexaem.). Tale inversa proporzionalità è del tutto simile a quella verificabile a livello storico-politico: quando era forte l’unità tra le nazioni della Respublica christiana, sotto il vessillo ideale del Sacro Impero, debole era l’unità all’interno di esse; viceversa il rafforzarsi della compattezza interna dei singoli regni è andato di pari passo con lo sgretolamento di un comune riferimento sovranazionale. Sull’aspetto della univocità dell'essere cfr. J. Seifert, op. cit., cap. 7, in part. pp.295 segg.; il filosofo cattolico austriaco sottolinea la sostanziale compatibilità della dottrina scotista con l'analogia tomistica. Ciò che viene dimostrato ricorrendo,come già avevano in qualche modo fatto il Gilson (Jean Duns Scot, ed.Vrin, Paris 1952, pp. 84 segg.; p. 89: “l’univocité scotiste ne contredit pas l’analogie del’étre thomiste”) e il Copleston (Storia della filosofia,tr. it. Paideia, Brescia 1971,vol Il, pp. 629/37) distinguendo il piano logico, a cui solo si applicherebbe il discorso del Subtilis, da quello ontico, a cui si riferisce l’Angelico. Questa spiegazione non esclude quella che ci siamo permessi di suggerire, come ben si può capire.
[24] Intendiamo dire quindi che il tipo di analogia proposto da S.Tommaso pare troppo disgiuntivo per garantire la contemplazione nel concreto: occorre perciò non rifiutarlo, e nemmeno - in un certo senso - superarlo, ma certamente integrarlo con la prospettiva bonaventuriano-scotista,
[25] Gli accidenti infatti, per definizione, possono mutare senza che muti il nucleo sostanziale (la mela da verde diviene rossa, restando quella mela, quella stessa sostanza). Ora se fosse un accidente ad individuare (questa mela è diversa da ogni altra mela, per il fatto di essere cresciuta sulla tal pianta [relazione], sita alla tal latitudine e alla talaltra longitudine [luogo], e di avere tot numero di atomi [quantità] del tale o del talaltro elemento [qualità]), al variare di uno di essi varierebbe anche la sostanza stessa, il che non può essere.
[26] In altri termini l’aristotelismo cristiano dell’Angelico resta, per certi aspetti, condizionato dall’intellettualismo ellenico, che gli impedisce di trarre tutte le conseguenze filosofiche dei dogmi della creazione e della Incarnazione, i quali conferiscono alla singolarità concreta un valore del tutto sconosciuto all'orizzonte greco,che privilegia il generico, l’universale. D'altro lato bisognerebbe aggiungere che lo scotismo deve essere a sua volta attentamente calibrato e filtrato, per evitare il rischio che la sottolineatura del singolare porti a conseguenze nominalistiche, tali da compromettere il valore della ragione (speculativa e pratica): l’haecceitas non va contrapposta, quasi la negasse, alla oggettiva e robusta struttura delle essenze universali.
[27] Di fatto, notiamolo en passant, abbiamo il sospetto che molto dell’attuale revival tomistico, sia funzionale non tanto ad una riscoperta del vero Tommaso (che nonostante certe accentuazioni discutibili e certe incompletezze resta una delle pietre miliari del pensiero cattolico), quanto ad una strumentalizzazione del tomismo, volta appunto a giustificare un orizzonte naturalistico e “anonimo”. In questo senso ci pare molto più fedele allo spirito del tomismo, e molto più onesto un von Balthasar, che relativizza a chiare lettere l'Aquinate, di un Rahner o di uno Schillebeeckx, che proclamano in qualche modo di rifarsi all'Angelico, mentre ne tradiscono profondamente l'impostazione.
🛒 ricerche / acquisti
cerca libri su Amazon sul tema: metafisica Bertoldi principium individuationis Tommaso Duns Scoto filosofia teologia università cultura libri on-line Contemplazione e metafisica .